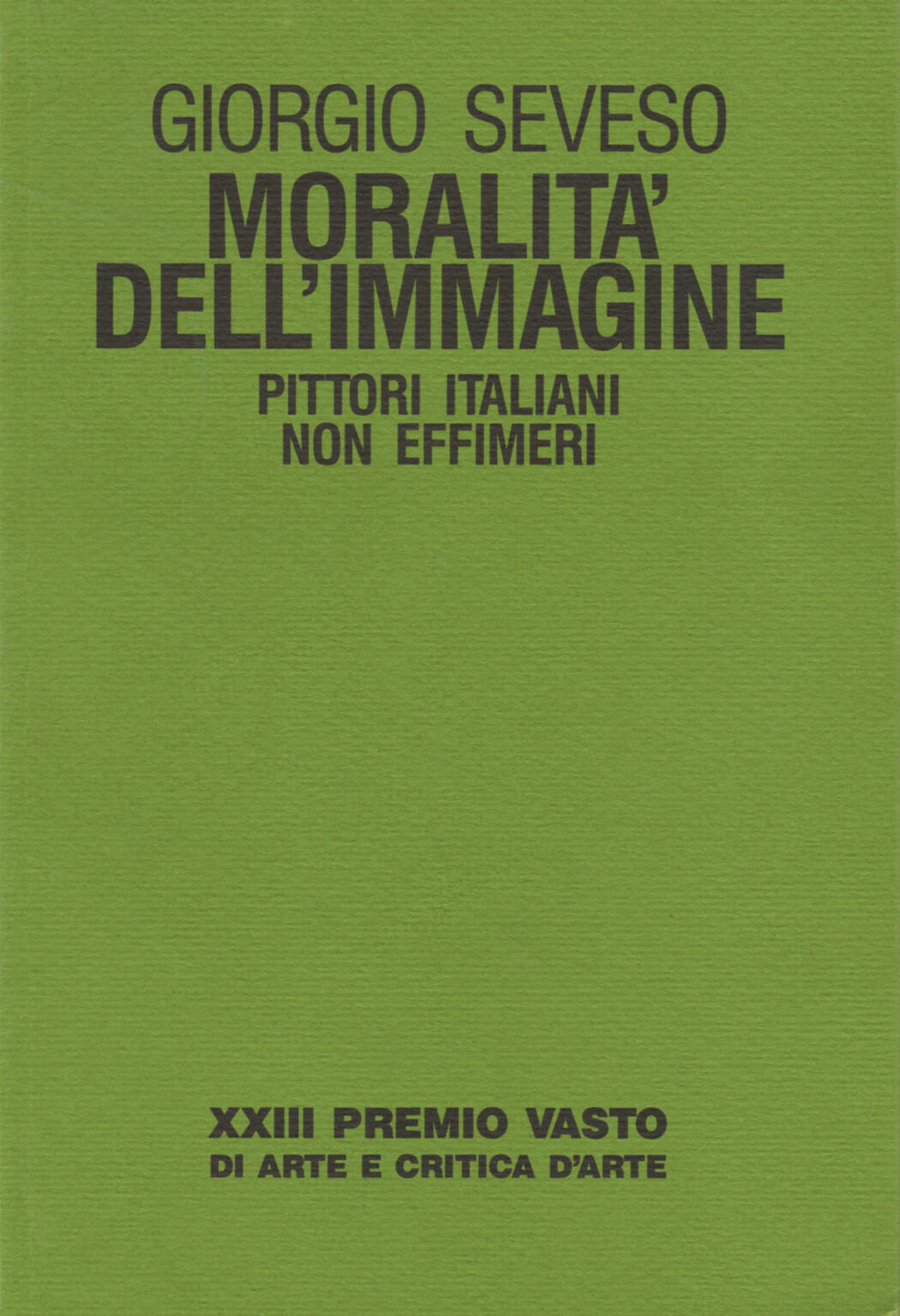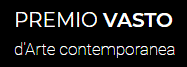Saggio inedito e rassegna collettiva Moralità dell’immagine. Pittori italiani non effimeri, a cura di Giorgio Seveso.
Una mostra di pittura collettiva ben di rado è casuale.
I diversi artisti che vi sono convocati rappresentano, tutti assieme, qualcosa che difatti va oltre le loro singole presenze o testimonianze individuali, che pure sono determinanti, per concorrere nelle loro affinità e differenze a definire collettivamente la ragione o il portato di una tesi, la giustificazione e l’esplicitazione di un “contenuto” preciso di ordine estetico, poetico o genericamente culturale.
Certo vi sono dei casi, tuttavia, in cui ciò non accade, in cui cioè l’assemblaggio delle presenze avviene per meri motivi d’ordine geografico (per esempio, stessa città d’origine o di residenza) o, peggio, per esclusive opportunità commerciali.
Beninteso, anche queste sono “filosofie” dell’arte che hanno motivi e segni precisi, ma esse come dire non appaiono: restano sepolte sotto le intenzioni dichiarate della rassegna rimanendo magari anche ignote o malcomprese agli stessi organizzatori.
Apparirà subito del tutto evidente allo spettatore, invece, il fatto che questa mostra, già dal titolo, nasce dichiaratamente per sostenere una tesi, per mettere a fuoco, con l’appoggio probante e robusto delle opere esposte, talune idee e giudizi che possono aiutarci a comprendere meglio e più in profondità alcuni tra gli snodi e ragioni che definiscono la nostra arte attuale.
Abbiamo infatti riunito qui venticinque artisti italiani d’oggi (Daniel Bec, per la verità, è francese ma vive e lavora qui da noi ormai da tanti di quegli anni che si può tranquillamente considerarlo, almeno per la pittura, un nostro connazionale): venticinque artisti che operano su presupposti formali assai diversi gli uni dagli altri, ma che pure presentano, malgrado ciò che può apparire ad uno sguardo frettoloso, più d’un motivo di contatto tra loro e più di una affinità pittorica.
Al punto che si potrebbe parlare di una sorta di poetica comune: di qualcosa che non ha ancora le caratteristiche ferme e precise di una vera e propria tendenza ma che, tuttavia, si può definire -se amassimo questo genere di formulazioni critiche – come una sorta di vero e proprio sguardo lirico sulla realtà, come una sorta di “realismo lirico”.
Come qualcosa, cioè, che obbedisce a spinte, pulsioni e idiosincrasie di tipo formale, segnico e linguistico sempre in qualche modo figurative, come si diceva una volta con termine che oggi non è forse più di moda, ma che soprattutto, e insieme, è attivo sul piano della qualità poetica dell’espressione, sul piano cioè di una particolare attenzione e tensione della sensibilità degli autori nei confronti della realtà fisica, fenomenica, esistenziale che li circonda.
Sono difatti le loro, complessivamente, scelte espressive e poetiche orientate verso una penetrazione fortemente metaforica, dilatante, trasfigurante del problema della forma e dell’ espressione, nel fuoco di un atteggiamento che si bilancia costantemente tra la verità oggettiva delle cose e della natura, vale a dire la densità di simulacro o di icona della rappresentazione pittorica convenzionale, da una parte, e, dall’altra, l’altrettanto densa valenza emozionale, testimoniale, sentimentale che sempre sommuove il segno pittorico quando vi sia vero talento e autentica partecipazione.
In altre parole, c’è in questi artisti una tendenza a penetrare sotto la pelle delle cose, della figura, della natura per farvi reagire sempre, senza mai abbandonarle o rimuoverle, il senso palpitante di uno sguardo trasfiguratore, di uno sguardo lungo capace di ogni più inaspettato brivido, di ogni più inquietante o dolce o ambigua metaforizzazione.
Il loro immaginario è di segno lirico fino alla vertigine, fino all’affabulazione più intimistica, più inconscia e magari in qualche caso più metafisica ma è sempre, anche, di segno rigorosamente mai arbitrario, mai evasivo o sfuggente rispetto agli autentici centri di gravità dell’uomo di oggi e dei suoi destini quotidiani, delle sue contraddizioni, delle sue speranze e disperazioni.
Si tratta beninteso, dicevo, di un realismo o, meglio, di realismi, secondo il titolo della grande mostra parigina di Jean Clair di due anni fa, che dovremmo scrivere tra virgolette, poiché gli slargamenti lirici dai quali sono percorsi li rendono in qualche modo profondamente soggettivi, assolutamente personali e magari anche talvolta ermetici.
Per quanto davvero nemmeno tra i più intimisti tra di loro l’immagine è mai così impenetrabile da non poter essere ri-costruita e compiutamente “letta” per il tramite della sensibilità del riguardante.
Ma, proprio per questo, si tratta anche di realismi che presuppongono da parte nostra accostamenti non effimeri, non superficiali.
Che presuppongono e comportano, insomma, nello spettatore, attenzione e disponibilità per una lettura non certo solo estetica delle immagini e delle loro diverse virtualità.
Non è difatti solo la pittura, non sono solo le sue modulazioni sensuose o i suoi gusti diversi e pur determinanti ad interessare questi artisti.
O, almeno, non è soltanto questa la sostanza complessiva della loro appassionata, assorta, generosa maniera di considerare il mestiere dell’ artista.
Al di là, diciamo, di ciò che qualcuno ha chiamato l’”erotica” del dipingere, che pure è presente per tutti loro in forme e modi ovviamente diversi e spesso anche ai bordi del più suggestivo e affascinante virtuosismo, il centro determinante del loro lavoro è costituito dall’ impulso a fare della pittura un media privilegiato e irripetibile di riflessione etica, uno strumento fortemente specifico d’espressione diretta del cuore e della mente.
Questo è ciò che li interessa e che li accomuna, e su questo va soprattutto incernierata la loro comune ricerca, dagli esiti tanto differenti quanto, a ben guardare, significativamente convergenti.
Ma anche, si deve aggiungere, sono proprio queste cose a distinguerli da una gran parte di ciò che oggi si viene facendo in campo d’arte.
Questi venticinque pittori e come loro ve ne sono altri, beninteso, che avrebbero qui ben figurato se non avessimo dovuto pur darci un limite di spazio e di rappresentatività sono infatti pittori che si portano dietro e dentro le ragioni di una forte e documentabile polemica nei confronti dell’ attuale sistema artistico, delle sue” mode” correnti e ricorrenti, dei suoi opportunismi, delle sue eroiche meschinerie e piaggierie, delle sue evasività e delle sue trame e tramette, oscure o palesi che siano.
E lasciamo lontane – per carità! – da questo discorso la politica o l’ideologia, che non hanno, almeno nell’ambito che questo commento si è dato, attinenza immediata.
E’ però certo che in questi ultimi anni il livello qualitativo degli atteggiamenti correntemente praticati nell’arte italiana (e non solo) s’è purtroppo adeguato all’andazzo di tutta la nostra vita culturale e civile, mutuandone modelli di comportamento che badano più ai valori del successo immediato, o diciamo del consenso ad ogni costo, che a quelli di una più faticosa, più sofferta pertinenza ideale e poetica.
L’effimero, il trasformismo estetico, il transitorio, il superficiale dettano legge: divengono arte “ufficiale”, mentre ciò che ha sapore d’impegno, di ricerca seria sugli snodi autentici dell’uomo d’oggi e dei suoi problemi, magari rimossi ma non risolti, viene di norma considerato, nel migliore dei casi, come una sorta di romantica sopravvivenza di atteggiamenti che non hanno più ragione d’essere.
Il lirismo e la realtà sono difatti, per i nuovi maitres a penser della critica e dell’ arte, qualcosa di irrimediabilmente superato, di vecchio, di inutile.
E dunque gli artisti che presentiamo, a commento concreto del saggio qui pubblicato, con le loro preoccupazioni, con il fascino straordinario delle loro immagini profondamente compromesse con la realtà delle cose, con quella loro variegata e complessa e problematica volontà o destino di “continuare” ciò che la grande pittura europea aveva cominciato almeno dal Rinascimento, ci appaiono e sono artisti polemici, artisti in qualche maniera contro, ineluttabilmente avversi agli orientamenti oggi criticamente prevalenti in questo campo.
Questo, in definitiva, è il terreno che li unisce.
Un terreno tanto più poeticamente e culturalmente eversivo, contestativo e polemico nei confronti degli orientamenti culturali prevalenti quanto più recupera la sovrana specificità di uno sguardo lirico sul mondo e sulle sue immagini, sull’intreccio emozionante tra la vita e l’uomo, le sue contraddizioni e le sue speranze.