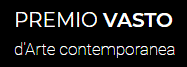Artisti giovani di fine Millennio
a cura di Carlo Fabrizio Carli e Gabriele Simongini
Il mito, i miti di Carlo Fabrizio Carli
Mito, miti: il mito per antonomasia, quello della classicità greco-romana, che, attraverso i secoli, ha continuato e continua ancora oggi ad esercitare la sua capacità fascinatrice, coinvolgendo gli artisti, beninteso nell’adozione di linguaggi e di attitudini moderne; e i tanti “miti” della contemporaneità – la macchina, i “divi” dello spettacolo e dello sport, il computer e quant’altro – che dell’antico mito, il cui ruolo e la cui funzione erano dunque ineliminabili dall’animo umano, hanno preso il posto, al pari di veri e propri surrogati.
Del mito, fu appunto Fiatone {Repubblica, 392 a) ad offrirci la prima definizione giunta fino a noi, come di racconti “intorno a dei, esseri divini, eroi e discese nell’aldilà”.
In realtà, come ebbe a dimostrare Furio Jesi (I), già nello stesso Platone i termini “mito”, “mitologia” presentavano la pluralità di significati, talvolta perfino reciprocamente conflittuali ed antinomici, che avrebbero poi sempre conservato fino ai nostri giorni, così da trascorrere dall’autorevolezza della rivelazione primigenia all’illusorietà della fantasticheria (non si dimentichi l’etimologia greca, per cui mùθos = favola).
Ma insomma, consapevoli che il mito costituisce una realtà culturale oltremodo complessa, è possibile giungere ad una sua definizione?
Scrive Mircea Eliade, con ogni probabilità il maggiore storico delle religioni che abbia annoverato il nostro secolo: “il mito narra una storia sacra; riferisce un avvenimento che ha avuto luogo nel Tempo primordiale, il tempo favoloso delle «origini» (2).
E ancora: “II mito è sempre la narrazione di una «creazione»: riferisce come una cosa è stata prodotta, ha cominciato ad essere” (3).
Nel generale processo di secolarizzazione e di omologazione anche il mito cambia, trasforma le sue originarie valenze sacrali, immanetizza la sete di primordialità numinosa.
Tale attitudine si manifesta mediante “una rivolta contro il tempo storico, il desiderio di accedere ad altri ritmi temporali al posto di quello in cui si è costretti a vivere e a lavorare” (4).
Eliade, non a caso grande esperto di narrativa, essendosi egli stesso cimentato – a fianco dell’attività scientifica – come narratore, con opere di incontestabile qualità, faceva riferimento in particolare al campo letterario; ma, a ben vedere, altrettanto può sostenersi anche riguardo il dominio delle arti visive.
“Finché sussiste questo desiderio – sono ancora parole dello studioso romeno – si può dire che l’uomo moderno conserva ancora almeno certi residui di un «comportamento mitologico».
Le tracce di un tale comportamento mitologico si rivelano nel desiderio di ritrovare l’intensità con cui si è vissuta o si è conosciuta una cosa per la prima volta, di recuperare il lontano passato, l’epoca beatifica degli «inizi».
Come c’era da aspettarsi, è sempre la stessa lotta contro il Tempo, la stessa speranza di liberarsi dal peso del «Tempo morto», dal Tempo che schiaccia e uccide” (5).
Mi scuso con il lettore per la lunghezza della citazione, che d’altronde mi sembrava illuminante, non solo riguardo l’individuazione della superstite praticabilità del mito nella realtà contemporanea, ma altresì per la messa a fuoco dell’attitudine mitica, capace di assicurare, offrendole l’impronta, tale praticabilità.
Il mito, i miti, dunque.
E gli artisti, perlopiù giovani e giovanissimi, selezionati in questa edizione del Premio Vasto ad offrire una testimonianza concreta di come, nel campo della creatività estetica, la dimensione mitica sia percepita e interpretata nel problematico crinale di fine secolo e millennio.
Mi sembra pure circostanza degna di segnalazione che, mentre dal punto di vista dell’età degli artisti presenti in mostra il segmento interessato risulta fortemente omogeneo, assai ampio e diversificato è invece lo spettro dei linguaggi e delle tecniche impiegate, che spazia dalla scultura alla pittura propriamente denotate, dall’incisione alle elaborazioni di computer art, agli interventi di marca oggettuale, alle istallazioni.
NOTE
- Furio Jesi, Mito, Mondadori, Milano 1980.
- Mircea Eliade, Mito e realta, Boria, Torino 1966, p. 27.
- M. Eliade, op. cìt, p. 28.
- M. Eliade, op. cìt., p. 226.
- M. Eliade, op. cit., pp. 226-7.
L’enigmatico volto del mito di Gabriele Simongini
L’arte come magia, rito e incantamento può rivelare tuttora la sua profonda sostanza mitica, nel senso etimologico del termine greco, mŷthos, ovvero narrazione, favola, leggenda.
E proprio ai giorni nostri l’energia mitica dell’arte può dare corpo ad un virus vitale che riesca a contrapporsi alla glaciale dittatura tecnologica del prodotto nuovo ad ogni costo in quanto sottomesso alle logiche del mercato: in tal senso il mito, come ha ben notato Maurizio Calvesi (1), è “il sacro laico” che aiuta a “ricordare ‘l’origine'”.
Secondo quanto ha lucidamente scritto Günter Metken, “se adesso ancora una volta ci si occupa dei miti, – purché non si tratti di giochi di citazioni come nel caso dell’architettura postmoderna – è per arginare il controllo invisibile di una realtà puramente mediale, che, con il processo di relativizzazione di tutto ciò che vediamo e udiamo, porta con sé una perdita di memoria che nessuna
banca dati è più in grado di compensare.
Il ricorso al mitico da l’impressione talvolta quasi di un atto di disperazione” (2).
In una civiltà che, come ha intuito Jean Baudrillard, ha perduto l’unicità e l’esemplarità del desiderio per sostituirle con banali surrogati, il rispecchiamento dell’arte nel mito, assai più che nella pura e semplice mitologia, pone un accento salvifico, un tentativo di ritrovare le radici psichiche e simboliche della nostra stessa vita interiore.
In questo senso il mito è senza fine e illimitato, è un labirinto di specchi in cui archetipi collettivi e memorie individuali, speranze e attese, ansie e inquietudini si fondono nel crogiolo dell’immaginario artistico, dove l’eternità è un volto enigmatico che non spiega ne nasconde alcunché ma solo accenna sorridendo.
In tal modo, per citare ancora quanto ha scritto Günter Metken, “i miti e le figure mitologiche sono diventate per i pittori figure mentali, immagini fluttuanti.
Può dipendere da questa indeterminatezza e vastità di interpretazione il fatto che i miti si offrano sempre di più come linguaggio universale per la comprensione visuale” (3).
Così il mito, in tutte le sue varianti storico-geografiche ed etniche, diventa oggi per la creatività artistica un vessillo di libertà immaginativa sostanziata di umanità demiurgica, uno sterminato vocabolario in cui il fonema elementare e il simbolo si identificano e si compenetrano trasformando l’arte in linguaggio magico.
“Il mito – ha scritto Mircea Eliade – è un precedente per i modi del reale in generale (…).
Rivela una struttura del reale inaccessibile all’apprendimento empirico-razionalistico” (4).
E, si può aggiungere, le sue stesse strutture “rappresentative” sembrano identificarsi con i codici della poesia e delle arti visive poiché, come ha notato ancora Eliade, “il mito esprime plasticamente e drammaticamente quel che la metafisica e la teologia definiscono dialetticamente” (5).
Il mito, con tutte le sue stratificazioni simboliche, può dunque essere oggi un pretesto poietico per rimettere in moto un meccanismo dell’immaginazione che vada in profondità, per confrontarsi con l’onda lunga del tempo, del sacro e per ritrovare il coraggio di creare opere idealmente capaci di sfidare il “giudizio” dell’eternità.
Quanto più le tendenze artistiche oggi di moda vanno verso una smaterializzazione pseudo-spettacolare dell’espediente che cerca invano di nascondere un’aridità creativa e linguistica, tanto più si sente necessaria l’affermazione di forme simboliche fondate sulla reazione alla perdita di memoria storica dei tempi attuali.
E poiché la nostra tensione percettiva di uomini di fine millennio sembra assoggettata alla caleidoscopica, seducente e superficiale “danza” della virtualità tecnologica e dell’onnipresenza massmediale, proprio la riscoperta del mito si configura per contrasto come ricongiungimento con le nostre fondamentali radici psichiche e biologiche, come “archeologia del profondo”, come verità dei desideri e delle paure.
Del resto, ha scritto George Steiner, “le stesse fondamenta delle nostre arti e della nostra civiltà […] sono mitiche” (6).
In questo contesto sono stati invitati al XXXII Premio Vasto alcuni artisti giovani, o tutt’al più appartenenti alla generazione di mezzo, per confrontarsi con quello che potremmo chiamare il “progetto-mito”, una sorta di psicomachia in cui si stabilisca una relazione dialettica tra leggende del passato e nuovi vessilli materiali o spirituali, tra i miti individuali e quelli collettivi, tra presenze
esemplari dell’antichità e modelli della contemporaneità, nella maggiore varietà possibile di linguaggi creativi.
Ne vien fuori un vitale percorso di segni, simboli, tracce, visioni che idealmente fa da ponte verso il sogno del futuro.
Gli artisti ora presentati a Vasto hanno quindi proposto un confronto con il mito concepito come profondità evocativa della “grande memoria”, la memoria del genere umano di cui hanno parlato prima il grande poeta irlandese William Butier Yeats e poi lo scrittore argentino Jorge Luis Borges.
In tale contesto e nel panorama dell’arte attuale è fondamentale affermare l’unicità inferiore dell’atto creativo, che deve necessariamente visualizzarsi in una forma inseribile nella continuità di un complesso processo storico.
Innumerevoli equivoci stanno nascendo tuttora tra le giovani generazioni intorno alla radice fortemente “concettuale” di molte opere collocabili nella fase eroica delle avanguardie storiche, dal “Quadrato bianco su fondo bianco” di Malevic ai “ready-made” di Duchamp.
È dunque una pura illusione quella di poter dare origine ad un’opera d’arte attraverso un banale processo di variazione o rielaborazione dell’impatto iconoclasta che sembra ad esempio caratterizzare i lavori di Duchamp, proprio perché egli ha raggiunto un tale grado di azzeramento operativo e mentale che non è certo riproducibile con i suoi stessi strumenti operativi e con la stessa intensità se non perdendo totalmente la profondità evocativa e la forza del gesto in sé concluso, carico di risonanze interiori che sfiorano il limite dell’insignificanza provocatoria.
Una possibile via d’uscita sta proprio nello svelamento dell’eterna attitudine mitica dell’arte e della sua catarsi ludica attraverso le varie tecniche operative: e non a caso nell’antica Grecia l’arte si chiamava Téchne e in Giappone Asobi, ossia gioco.
Ancora oggi la capacità di varcare la porta del mito può suscitare innumerevoli sorprese.
NOTE
- M. Calvesi, “Asterischi intorno al mito e all’arte (di oggi)”, in catalogo della mostra “L’Ombra degli Dei. Mito greco e arte contemporanea”, Civica Galleria “Renato Guttuso” – Villa Cattolica.
Bagheria, 9 maggio -12 luglio 1998, Electa Napoli, p. 15. - G. Metken, “La sfida di Icaro”, in catalogo della mostra “L’Ombra degli Dei. Mito greco e arte contemporanea”, cit., p. 79.
- G. Metken, op. cit., p. 83.
- M. Eliade, “Trattato di storia delle religioni”, Editore Boringhieri, Torino 1976, p. 431.
- M. Eliade, op. cit, p. 433.
- G. Steiner, “Le Antigoni”, Garzanti, Milano 1990.
Scultori ceramisti a Castelli di Carlo Fabrizio Carli
La consueta mostra “omaggio” allestita in occasione del Premio Vasto è dedicata quest’anno al gruppo di scultori ceramisti di Castelli che, nell’ultimo ventennio, ha riproposto con linguaggi tutti moderni l’insigne tradizione d’arte che fece del centro abruzzese, demograficamente esiguo e geograficamente defilato dalla mappa del potere del tempo, una delle capitali della ceramica europea, tra Cinque e Settecento.
Le ceramiche cinquecentesche della produzione “Orsini-Colonna”; l’istoriato uscito, nel corso del XVII e XVIII secolo, dalle celebri botteghe dei Grue e dei Gentile, occupano oggi preziose vetrine nei principali musei di mezzo mondo.
Un ruolo prezioso l’ha svolto fin dalla fondazione, all’inizio del secolo (dopo una lunga preparazione), la locale Scuola d’arte per la ceramica, che ha contribuito a mantener viva la tradizione figulina, richiamando a Castelli, nel ruolo di insegnanti, artisti validissimi, da Giorgio Baitello a Guerrino Tramonti, tanto per fare dei nomi.
Il gruppo dei ceramisti castellani, ormai non più attivo nella sua aggregazione, conobbe in passato importanti momenti espositivi comunitari, a cominciare dalla rassegna “Artetempo”, tenutasi nel 1987, a cura di Enrico Crispolti e Luigi Paolo Finizio, nel Museo delle Ceramiche di Castelli (assieme a Cheng, Di Giosaffatte, Sciannella, esponevano in quell’occasione anche Roberto Bentini Giorgio Saturni).
Fausto Cheng, Vincenzo Di Giosaffatte, Giancarlo Sciannella sono – va subito detto – degli scultori a pieno titolo.
Molto spesso, il materiale ceramico riconduce il pensiero ad un repertorio artigianale ed utilitario, ad una declinazione ancillare della creatività estetica.
Nel caso dei nostri tré artisti, tale accezione risulterebbe – ancor prima che ingiustamente riduttiva e penalizzante -criticamente fuorviante.
Scultori, quindi, che impiegano il mezzo ceramico, invece, poniamo, del marmo o del bronzo, e in quanto tali esponenti di una pagina d’arte che è, ai nostri occhi tra le più singolari e significative dell’arte abruzzese del secondo Novecento (e non è riconoscimento da poco, stante la nota vivacità del panorama artistico regionale).
Appunto in virtù di tale qualità, essi sono destinatari dell’odierno “omaggio” del Vasto; tuttavia occorre anche rilevare che la loro presenza non è, a ben vedere, estranea alla tematica prescelta per la sezione principale della rassegna – il Miti i Miti -, assecondandola anzi in modo singolare.
Cominciando proprio dalla considerazione generale che l’artista che plasma l’argilla, che imprime la forma alla massa casuale della materia ; il più prossimo all’attitudine creazionale.